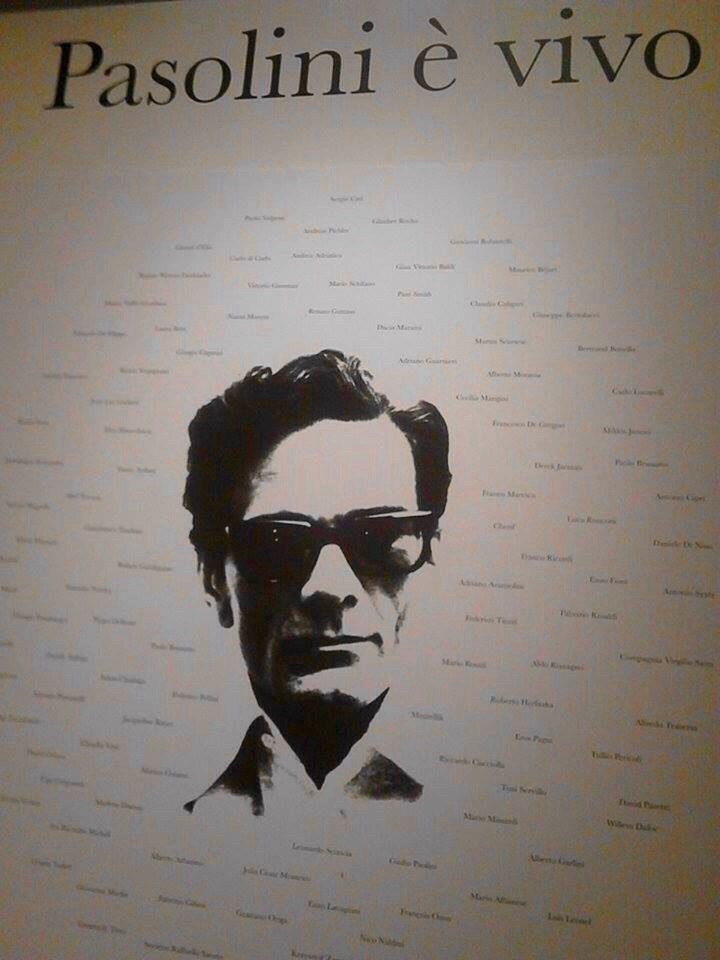Sabato 21 maggio mi sono ritrovato all’ultima data del concerto dei Muse al Mediolanum Forum di Milano. Il viaggio di ritorno in quei comodi pullman appositamente organizzati per portarti ai concerti, in mancanza di un cellulare abbastanza carico per addormentarsi con la musica, ha di certo stimolato varie riflessioni. Un concerto molto bello: i Muse sempre degli ottimi animali da palcoscenico, forse al giorno d’oggi una delle migliori band dal vivo. Eppure mi rimaneva una nota di amaro in bocca. Da cosa poteva essere scaturita? D’altronde la scaletta, di poco diversa rispetto a quella delle altre cinque date precedenti, non era stata per niente male. Drones è di certo un album che li riconnette un po’ alle orgini (of symmetry, per citare un loro vecchio album) ma che esce fuori anche dagli ultimi album più pop (vedi brani come Mercy o Revolt). La riflessione di fondo invece è partita da altro. La messa in scena è stata decisamente spaziale: maxischermi e teloni, palco girevole a 360 gradi, coriandoli, fumo e veri e propri droni volanti. Le sfere illuminate e la navicella spaziale hanno di certo sorpreso più di ogni altra cosa il pubblico, che ha gridato alla novità (seppure a far volare palloni aerostatici ci avevano già da tempo pensato i Pink Floyd). Di fronte a tutti questi effetti scenici perciò, l’entusiasmo del pubblico: ma un entusiasmo strano. Premetto di essermi forse -senza volerlo- trovato in un angolo del parterre un po’ apatico nonostante fosse incredibilmente vicino al palco. Pochi poghi visibili (che forse è anche un bene) ma anche poco movimento in generale. Di fronte alle mirabilie dello spettacolo la gente si fermava a guardare. Certo, concerti del genere ormai raccolgono gruppi eterogenei di persone, dai più incalliti rockettari alle famiglie tranquille, da antichi fan del gruppo a scelte occasionali. Perché: “Sì dai, mi hanno detto che è un bello spettacolo e poi conosco almeno due canzoni. Quasi quasi ci vado”. E ci sta. Ma la particolare circostanza di quell’angolo sfortunato, animatosi veramente tanto al solo passaggio del cantante vicino, mi ha fatto domandare: riusciamo veramente più ad emozionarci durante un concerto?
Perché, viziati come siamo da schermi ed effetti speciali, non ci accontentiamo che di luci sempre più grandi, di immagini che ci avvolgono a 360 gradi, di ottimi pasti per sbalordire i nostri occhi. Ma la musica non è questo. Ovvero può esserlo, se accompagnata da ottime atmosfere come quelle di un concerto dei Muse. Ma un concerto dei Muse è da vedere e anche da sentire, e di fronte a tutte le mirabilie ho visto più cellulari brillare che gambe saltare. Nulla di nuovo: è la nostra generazione, la nostra società, la nostra inintermittente connettività. Ma non è un po’ strano ritrovarsi in un concerto di maxischermi per poi riprenderlo con altri schermi (del proprio telefonino) grazie ai quali si potranno rivedere video e foto su altri schermi del pc (una volta condivisi su Facebook) o della vostra televisione (una volta che del concerto ne sarà uscito il cd con le riprese ufficiali)? Si è riusciti a viversi veramente quel concerto? In questa agonia di cristallizzare ogni attimo in una foto, di condividere e condividere i propri video su Facebook o Snapchat a costo di farlo durante il concerto stesso, si rischia di rivolgere più sguardi al proprio cellulare che a gesti della band sulla scena. Questo, solo per far sapere a tutti di esserci stati. Ma esserci stati in che modo? Dietro lo schermo sempre acceso di uno smartphone? I cellulari possono essere delle armi micidiali: sì, anche perché con tutti i loro flash possono da fastidio al gruppo (così come ha intimato la security a inizio concerto) ma anche perché, detto proprio banalmente, rischiano di farci cadere nell’alienazione, proprio quell’alienazione che i Muse hanno cantato nei loro brani. E allora forse, fantasticando su un’umanità futura popolata da freddi e omologati droni, ecco allora ci si riferiva proprio a noi del pubblico.
La mia è probabilmente una leggera esagerazione. E sta di fatto che ciascuno vive un concerto a modo suo e che può scegliere se relegare alle proprie dita il compito di fare delle corna rockettare o di tenere fermo lo schermo di un cellulare. Forse una sesta data in una settimana e mezzo rischia di raccogliere più gente eterogeneamente appassionata del gruppo. Non che persone che magari siano venute per passare una serata diversa senza essere grandi fan non dovessero farlo, per carità. Ma tutte quelle luci e immagini e droni forse hanno rischiato di togliere l’attenzione da un audio non del tutto perfetto. Sì, mi trovavo anche un angolo sfortunato forse, ma cosa ci veniamo a fare a un concerto se non per ascoltare? Probabilmente stiamo anche cambiando, società, gusti, interessi, e forse anche il nostro modo di intrattenerci. Il nostro sguardo si è raddoppiato: ha sempre più bisogno di sdoppiarsi anche dietro a uno schermo, come se i soli occhi non bastassero a registrare le sensazioni che viviamo. Perché per sentirlo veramente vivo un attimo, non dobbiamo per forza condividerlo sui social network. I Muse sembrano comunque riuscire a incontrare vecchi e nuovi tipi di intrattenimento, e riescono a farlo con molto stile e molta professionalità. Ma non posso evitare di chiedermi: riusciremo ancora in futuro ad emozionarci veramente per un concerto?
Ariele di Mario