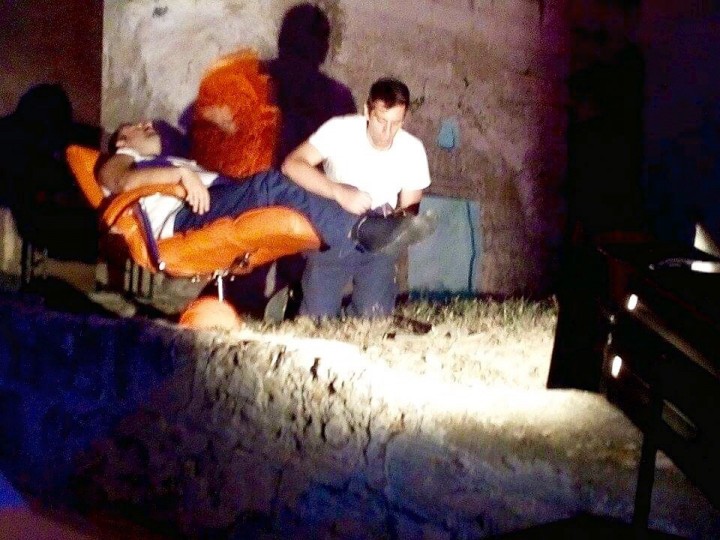“In nome del progresso, l’uomo sta trasformando il mondo in un luogo fetido e velenoso. Sta inquinando l’aria, l’acqua, il suolo, gli animali e se stesso, al punto che è legittimo domandarsi se, fra un centinaio d’anni, sarà ancora possibile vivere sulla terra”. Questa citazione di Erich Fromm rappresenta con schiettezza cosciente il problema principale ma nettamente deviato dalla società: l’abuso ambientale. Nel 2014 è stato pubblicato “Cowspiracy: the sustainability secret”, un documentario prodotto e diretto da Kip Andersen e Keegan Kuhn in cui viene illustrato l’impatto dell’allevamento e dell’industria animale sul pianeta. Secondo ciò che ci viene insegnato fin da bambini, bisognerebbe migliorarsi nel quotidiano, utilizzando l’automobile di rado, facendo docce brevi, spostandosi in bicicletta, ecc. Ma queste convinzioni furono spezzate quando Kip Andersen ricevette da un amico un rapporto delle Nazioni Unite, che affermava come le mucche producano più gas serra che l’intero settore dei trasporti, oltre ad un documento della Food and Agricolture Organization of US che illustra come l’inquinamento prodotto dai mezzi di trasporto ha un impatto ambientale minore di quello del bestiame, in quanto le mucche producono notevole quantità di metano tramite il loro processo digestivo. Quindi l’interrogativo sorge spontaneo: le varie azioni di ogni giorno non legate al campo agro-alimentare che ci vengono insegnate da sempre, per quanto siano importanti, possono ad oggi contribuire seriamente alla risoluzione del degenerato problema ambiente? La questione che desta più perplessità è che i dati raccolti dai produttori di Cowspiracy non sono diffusi nè pubblicizzati nelle campagne delle principali associazioni ambientaliste. I documenti di queste, appunto, e del governo statunitense sono incentrati sulle emissioni di gas naturale, petrolio e soprattutto fatturazione idrica, per l’aumento notevole della siccità. Ogni anno negli USA vengono usati più di 100 miliardi di galloni d’acqua dagli uomini, ma nulla in confronto all’acqua utilizzata per l’allevamento di mucche, che supera i 34 trilioni di galloni. Per questo i produttori hanno voluto intervistare enti ambientali ed esponenti governativi, interrogandoli sulla questione relativa agli allevamenti intensivi di bestiame e soprattutto sulle cause del silenzio legato all’argomento, in quanto nessuno avrebbe mai pensato che mangiare carne e derivati animali potesse essere più dannoso che utilizzare ogni giorno la propria automobile per andare a lavoro. Ogni interlocutore intervistato ha deviato il tema, e nel momento in cui gli veniva posta la domanda apposita, dietro ad un notevole alone di imbarazzo e timore, nessuna risposta.
Ciò che viene maggiormente violato per sostenere la produzione intensiva ed eccessiva di carne, latticini e uova, sono le foreste pluviali, i polmoni del mondo che assorbono CO2 e rilasciano ossigeno. Ogni secondo viengono abbattuti 4.047 m2 di foresta pluviale, con lo scopo principale di creare coltivazioni per produrre il mangime vegetale degli animali d’allevamento. Ma anche intorno a questo tema si è riscontrato l’imbarazzante silenzio di Lindsey Allen, la direttrice esecutiva di uno dei più grandi gruppi di protezione delle foreste, di fronte alla richiesta di informazioni. Amazon Wath è stata l’unica associazione che ha parlato semi-apertamente del problema, e ha detto a chiare lettere che il mercato di allevamento del bestiame è la principale causa dei problemi ambientali odierni. Ha anche parlato del tema riguardante gli assassini brutali di oltre 1.100 ambientalisti: in Brasile, dopo l’approvazione del Codice Forestale, le persone che si sono opposte alle lobby e agli interessi delle grandi imprese agro-alimentari sono state uccise, tutte persone che dicevano apertamente che gli allevamenti intensivi stavano distruggendo l’Amazzonia, come Dorothy Stang (1931-2005), una suora vissuta in Para che ha parlato apertamento del problema, uccisa a bruciapelo da un sicario assunto dall’industria del bestiame.
I produttori del documentario non si sono limitati a ciò, ma hanno anche intervistato e conosciuto proprietari di allevamenti definiti sostenibili, per esempio la fattoria di manzo Markegard in California, in cui lavora l’intera famiglia proprietaria, la quale illustra come produce direttamente carne e derivati animali senza causare danni ambientali. Ma le quantità prodotte in questo modo sono scarsissime, e considerando la notevole quantità di consumo di tali prodotti alimentari, non basterebbero a sfamare la popolazione occidentale abituata a uno stile di alimentazione eccessivo e ricco. Quindi se tutti vogliono mantenere il consumo attuale di prodotti animali, inevitabilmente il risultato è l’allevamento intensivo, perchè un modo sostenibile di produzione che possa garantire quantità esorbitanti non esiste.
La soluzione al problema suggerita da esperti ed onesti ambientalisti intervistati, è quella di adottare a livello quotidiano una dieta che elimini o riduca notevolmente il consumo di derivati di animali, in quanto tale consumo, oltre ad essere causa di problemi salutari all’essere umano, sta portando alla distruzione del mondo, che non supererebbe i 50 anni di vita se si continuasse questa spasmodica speculazione sul cibo.
Quando i produttori hanno ricevuto la notizia circa la sospensione dei finanziamenti per procedere col documentario, a causa del fatto che l’indagine stava diventando talmente delicata e approfondita da metterli in pericolo, essi sono andati a parlare con una vittima diretta del sistema, Howard Lyman, citato in giudizio da allevatori per aver detto la verità riguardo l’allevamento intensivo nel programma TV “The Ophra Winfrey”. Egli spiega come il causare interruzioni nei profitti dell’industria animale sia pericoloso, e Will Potter, autore di “Green is the new red” spiega che questi generi di campagne sono considerati dall’FBI come terrorismo interno, egli per esempio tramite la legge sulla libertà di parola è venuto a conoscenza di documenti dell’unità federale rivelatori del suo essere tenuto sotto controllo da tempo dall’unità anti-terrorismo.
La paura è il motivo per cui nessuno vuole parlare. Ma la paura non è nulla di fronte al fatto che l’82% dei bambini che muoiono di fame vivono nei luoghi in cui il cibo viene utilizzato per nutrire il bestiame allevato, ucciso e mangiato dalle popolazioni più ricche. Oggi potremmo nutrire tutte le persone del mondo se ci fosse una dieta adeguata ed equilibrata alla convivenza di 7 miliardi di persone e se prendessimo il cibo destinato agli animali e lo utilizzassimo per gli uomini.
Ma in tutto ciò non è stato ancora toccato un ulteriore tema etico di non poca importanza: per sostenere questo stile alimentare vengano sfruttati ed uccisi esseri viventi, fondamentali per il sistema che regge l’ambiente. Ad un medico vegano é stato chiesto se questa tipologia di dieta, forse unica radicale soluzione del problema ambiente, possa essere dannosa per l’uomo. La sua opinione è a favore della stessa, oltre che per un fattore etico, anche per un fattore salutare, in quanto il consumo smodato di derivati animali sta causando l’ insorgere di malattie legate all’alimentazione, e ciò porta anche ad un consumo eccessivo di farmaci a livello quotidiano, che migliorano lo stato salutare immediato, ma non vanno a colpire la vera causa della malattia; basti pensare all’aumento della vendita di farmaci per abbassare i livelli di colesterolo, diabete, pressione alta, ecc, che non risolvono in radice il problema – legato all’alimentazione – e che hanno effetti collaterali non irrilevanti.
Sono successivamente stati intervistati agricoltori bio-intensivi che spiegano come per nutrire una persona vegana siano sufficienti appena 688 m2 di terreno, per una persona vegetariana tre volte tanto, mentre per un onnivoro occorrano diciotto volte più terreno, oltre al risparmio enorme a livello di produzione di sostanze inquinanti e consumo di acqua.
Il discorso più importante per arrivare a risultati che consentano la valorizzazione della vita umana prima ancora che dell’ambiente è legato alla sensibilizzazione. Se ogni volta in cui un uomo mangia pensasse agli affetti collaterali su se stesso e sul prossimo, migliorerebbe senza dubbio le sue abitudini, non come costrizione, bensì come libertà. In Italia si assiste ad un rispetto quasi religioso della tradizione alimentare, un rapporto quasi di venerazione del cibo buono in ogni sua regione, ma anche qui si sta vivendo sempre più il distacco tra ciò che si mangia e la sua provenienza, e nonostante ciò non si assiste ad un cambiamento quotidiano, quanto piuttosto ad una sorta di chiusura mentale verso il nuovo necessario. Eccesso non è sinonimo di benessere, ma spesso è un falso sorriso, pieno di frustrazione creata appositamente da un sistema che contribuisce ad autofinanziarsi sulle spalle di uomini e pianeta. Abitudini migliori portano ad una connessione quasi spirituale in vari campi della vita, ma soprattutto il sorriso reale dato dal contribuire per una buona causa.