
Non sono solita commemorare gli anniversari dei morti per mafia. O meglio lo faccio sì, ma nel mio intimo. Non apro mai la porta a pensieri pubblici perché non mi riesce. Ma c’è un giorno dell’anno, il 9 Maggio, dove mi devo fermare per fare entrare un’occasione naturale di memoria. La colpa non è del giorno, né di me stessa, la colpa è di Peppino Impastato. Perché la morte non sta bene addosso a nessuno, ma men che meno doveva stare bene addosso a Peppino. E mi sale una rabbia come se fosse stato un mio fratello, un mio cugino stretto, come se fosse stata una persona che amavo a tal punto da non poter sopportare il peso di un male che è stato fatto anche a me. Sarà che gli altri signori della legge, gli altri eroi della giustizia, noi ce li ricordiamo adulti, quasi vaccinati contro il dolore. Peppino invece aveva la mia età. E aveva tutte le stesse declinazioni della vita che si custodiscono quando si hanno vent’anni. Ascoltava i Beatles, sognava di innamorarsi veramente, leggeva Pasolini, gli piaceva la fotografia, faceva radio. Certe volte mentre camminava si doveva fermare per guardare più a lungo un posto. Per sognare come cambiarlo. Gli piaceva fare casino nei centri sociali, gli piacevano le giornate di sole a Cinisi e il rumore del mare. Come tutti i diversi, come tutti quelli che hanno una sensibilità in più nel voler trasformare le sovrastrutture del mondo, ha dovuto lottare anche contro gli scherzi della sua fragilità. Perché voler cambiare le cose vuol dire sempre misurarsi con la rinuncia di adagiarsi a quello che di sicuro già c’è. Chissà se gli sarà mancato l’amore di una donna quando tutti avevano paura di avvicinarsi perché la sua vicinanza era già pericolo, chissà se gli sarà mancato l’abbraccio stretto di suo padre negli anni in cui furono lontani per divergenze troppo grandi e troppo profonde di pensiero. Chissà quante volte, seduto sulla sua seicento azzurra, con la radio accesa sotto, si sarà fumato una sigaretta e si sarà chiesto se ne valeva veramente la pena. Il prezzo per cambiare l’umanità è quello di allontanarsi dall’umanità? Il prezzo per essere un eroe, qual è? Quello di spegnere la propria vita per accendere quella degli altri? Quello di essere ricordati per sempre sì, ma mentre non ci siamo più, mentre non la possiamo respirare né sentire questa memoria di onnipotenza sulla nostra carne?
No, Peppino queste cose non se le sarà chieste. Perché questi sono i miei pensieri, e come tali sono fragili, inferiori. Perché non sono un eroe e non avrei mai avuto il coraggio di andarmene via di casa e di rinchiudermi in un garage a sopravvivere con i soli guadagni della mia lotta. Perché non sono un eroe e non ce l’avrei fatta a continuare a gridare che la Mafia è una montagna di merda in un paese dove stavano già pianificando il mio omicidio. Queste domande Peppino non se le sarà fatte perché aveva solo le risposte. La sua idea di bene, la forza del vento che spazzava via forte la paura in Sicilia, la certezza che vent’anni sono pochi per vivere tutto quello che c’è da vivere nella vita, ma bastano per rendere immortale un attimo, un gesto, una passione.
A Peppino devo la mia riconoscenza, tutte le mie parole. Anche la più piccola cosa che diventerò avrà dentro di sé una parte piccola del suo coraggio. Ogni volta che passo da Cinisi mi sembra di sentirla la musica che suona dai balconi di Radio Aut, e mi sembra di intravederlo, magro, coi capelli neri, fra gli alberi di limoni che costeggiano le strade del paese. Vorrei andare lì abbracciarlo, fargli sentire la vicinanza di un tempo che non lo ha dimenticato. Poi sfugge. È stata solo un’impressione. Ma io ci credo che è ancora lì e ci guarda e continua a prendere in giro la nostra paura.
Veloce come il vento

Cosa sta succedendo al cinema italiano? Domanda difficile ed impegnativa che coglie alla sprovvista lo spettatore più attento, mentre stranito si chiede se sia ancora possibile girare film decenti nel Bel Paese. Interrogativo lecito che ha cominciato a circolare tra le folle dopo l’uscita di Lo chiamavano Jeeg Robot, esordio al fulmicotone del bravissimo Gabriele Mainetti e vincitore di sette statuette del David di Donatello. Ora una risposta certa sembra sempre più vicina. Veloce come il vento è una rivelazione sorprendente, un film splendido e commovente intriso di adrenalina e una giusta dose di ironia tipicamente romagnoleggiante.
La storia è incentrata sulle vicende di Giulia – l’esordiente e brillante Matilda de Angelis – giovane promessa delle corse a quattro ruote e del turbolento rapporto con suo fratello maggiore Loris – uno straordinario Stefano Accorsi – ex campione delle corse, ma ormai tossicodipendente. Vibrante di passione per la velocità estrema e affranta nel profondo a causa della disastrosa condizione famigliare, Giulia dovrà vincere una sfida più grande di lei in cui la posta in gioco non sarà solo l’onore e la gloria della vittoria. Il giovane Matteo Rovere dirige un film avvincente ed emozionante in cui l’azione frenetica delle rombanti gare automobilistiche si amalgama perfettamente con scene più rilassate, che ritraggono la quotidianità non sempre felice della famiglia De Martino. Rovere delinea con grazia il rapporto amore-odio tra i due fratelli, spesso in lite tra loro ma nel profondo ancora legati da un amore fraterno che nel corso del film li condurrà ad una riappacificazione definitiva. Giulia, malgrado la giovane età, porta avanti la famiglia tra pesanti sacrifici e profonde incomprensioni, mentre Loris, rovinato dalla tossicodipendenza e dalla depressione, è una persona ingestibile che procurerà grossi problemi alla stabilità della famiglia. Distrutto nel corpo ma ancora lucido nell’anima, Loris conserva dentro di sé lo spirito e lo straordinario talento del pilota che fu, un brillante campione detto “il ballerino”, che si rivelerà fondamentale per la risoluzione degli eventi.
Un film che pone l’accento sull’importanza del sacrificio e dell’impegno, armi necessarie per l’ottenimento di qualcosa, ma anche su quello del riscatto e, se pur in maniera ridotta, della redenzione. Argomenti nobili trattati da Rovere in maniera decorosa e che ricordano in parte le atmosfere che contraddistinsero la saga cinematografica di Rocky, le condizioni sociali del portagonista e la scalata verso il successo. Un film che sa anche divertire e strappare molte risate grazie alla tipicità equilibrata ed intelligente della cadenza romagnola, marchio di fabbrica di molti personaggi, permettendo allo spettatore di immergersi maggiormente nella storia narrata.
Veloce come il vento è un’opera decisamente riuscita che, nonostante la troppa prevedibilità in certi passaggi, riesce a trasmettere così tanta energia e passione da tenere il fiato sospeso dall’inizio alla fine. Film come questi potrebbero essere la giusta risposta alla macelleria culturale che il cinema italiano propone da ormai trent’anni, un cinema profondamente afflitto da una crisi di idee e innovazioni ma che, puntando su giovani talenti volenterosi come Rovere e Mainetti, sarebbe in grado di superare. Forse il cinema italiano sta riacquistando una coscienza propria, manifestando i primi segnali di un profondo e radicale miglioramento che vogliamo vedere.
Che giorno è il giorno dopo dei siciliani onesti?
Che giorno è il giorno dopo dei siciliani onesti? Il giorno dopo è sempre il figlio del giorno prima e non si può cancellare in una sola buona dozzina di ore il sapore amaro di quest’altra speranza che muore. Ma ho sentito frasi troppo gravi per dargli il mio lasciapassare ad esistere: “è finita”, “non bisogna credere più a niente”. Svegliamoci. L’unico modo per consentire a Pino Maniaci di essere ancora un eroe è dargli ancora il potere di farci crollare tutto come se lui fosse il rappresentante di quel tutto. Pino Maniaci, a quanto pare, non era l’uomo modello dell’antimafia. Ma l’antimafia non è un solo uomo. L’antimafia è il giornalista che fa il suo dovere, ma è anche l’insegnante che educa al rispetto di una norma di legalità, è un consigliere che vigila sul territorio, ma è anche un ragazzo che non accetta la raccomandazione per quel concorso pubblico. È vero, siamo stanchi. Siamo stanchi di sentirci presi in giro dai galantuomini della legalità che sono intrisi fino al collo di compromessi e mazzette e si sono permessi di venirci a fare la morale per anni. Ma che vogliamo fare? Vogliamo buttare via quello che siamo diventati anche grazie a questi esempi? L’inceppo del sistema sta qui: Pino Maniaci sarà anche un falso, ma l’impegno con cui noi lo abbiamo seguito era vero. Noi e la nostra crescita morale rimangono vere a prescindere dai personaggi che possono avere costellato ed alimentato il percorso. E questo ce lo dobbiamo ricordare perché altrimenti ci sentiremo derubati della nostra storia. Aver creduto in un giornalista che si professava libero da qualsiasi mafia ci ha fatto crescere come uomini liberi. Ci ha fatto praticare una scelta tra il bene ed il male, tra chi volevamo sentire e chi volevamo mettere a tacere. E questo dato rimane come tassello della nostra identità ideologica. Che lui poi si sia rivelato un sempliciotto che non possedesse un’idea vera della giustizia, questo è un fatto che lo debilita nella sua individualità di uomo e di professionista. Ma non ci può ledere. Ci può deludere.
Non voglio entrare nel merito della vicenda giudiziaria perché sono in corso indagini accurate ed è inutile professare condanne prima del tempo. Ma ciò che emerge dalle intercettazioni è così lampante che sarebbe anche un po’ ipocrita non formulare quantomeno giudizi personali. A Pino Maniaci voglio solo dire che per essere eroi ci vuole una certa stoffa. Cioè si può giocare a fare tanti mestieri, però per quello dell’eroe o ci nasci o ci muori. Ed inventarsi paladini della giustizia senza avere chiaro il concetto di giustizia corrisponde a giocare a fare il medico senza avere chiaro il concetto di salute o di malattia. E ci si può ammalare facilmente quando non si hanno chiari i concetti e soprattutto quando si cerca di confonderli agli altri.
Detto questo, gli rendiamo merito per il valore aggiunto al territorio con alcune delle sue importanti inchieste. Anche se non sappiamo a quale prezzo di dignità gli siano costate. Ma diciamo che oggi non siamo proprio in vena di ringraziamenti, quindi non ci dilungheremo nell’ elenco. L’elenco degli altri eroi invece, quelli veri,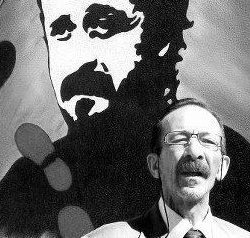 è lungo. E oggi rileggeremo con piacere solo quello.
è lungo. E oggi rileggeremo con piacere solo quello.
Ma, finita l’Università, che fai? Resti o torni a casa?
Ma, finita l’Università, che fai? Resti o torni a casa? Questa è la domanda che tanti studenti fuorisede a Bologna, specie se provenienti dal nostro Mezzogiorno, si sono sentiti porre, almeno una volta. Una domanda alla quale, inevitabilmente, hanno dovuto dare (dopo averla trovata) la loro personalissima risposta. Dietro una domanda di questo tipo c’è una legittima curiosità: il desiderio di sapere se, finita l’esperienza bolognese, questa venga messa da parte, appesa come un titolo sul muro dei ricordi e delle esperienze; oppure, al contrario, se abbia ancora qualcosa da dire e che, con forza, si sostituisca definitivamente al mondo passato, fatto di luoghi e conoscenze miste a nostalgia. Una domanda che tocca nel profondo lo studente, che si avvia a concludere il suo corso di studi e si ritrova di nuovo, immediatamente e quasi senza rendersene conto, di nuovo davanti ad un bivio fondamentale. Questa domanda si collega ad una risposta, sofferta o meno, ragionata o istintiva. Una risposta che tante volte entra in contatto con uno dei temi sul quale noi tutti, come cittadini italiani, ci interroghiamo fin dall’inizio della nostra esperienza nazionale: la cosiddetta (e ormai mitica) questione meridionale.
Dentro questo mondo fatto di domande e richieste mai sopite, rientra il tema dell’emigrazione. Sia chiaro: in un mondo globalizzato, “piccolo” ed interconnesso, nascere e crescere in un luogo per poi lasciarlo e trasferirsi in un altro, e poi in un altro ancora, è la norma. Anzi: è una legittima pretesa ed anche un prezioso privilegio (che vediamo messo a dura prova in questi giorni fatti di muri da innalzare in frontiere riscoperte). Se poi si pensa alla grande massa di studenti italiani che, conclusa la loro esperienza formativa, cercano (e spesso trovano) lavoro all’estero, il tema dell’emigrazione Sud-Nord all’ interno del nostro piccolo territorio nazionale può sembrare del tutto marginale ed indifferente.
Ancora: è bello immaginarsi cittadini del mondo, liberi di scegliere il luogo dove si intende costruire la propria storia e vivere l’incredibile varietà delle nostre città, veri e propri micro-cosmi a sé stanti: Patria est ubicumque est bene, dicevano i latini, con illuminante saggezza. A maggior ragione, da cittadini italiani, è giusto sperimentare. E, allora, stando così le cose, perché l’emigrazione dal Meridione è un problema? E perché il “resti o torni a casa”, domandato ad uno studente del Sud, è una domanda particolarmente sensibile?
Perché un intero pezzo del nostro Paese ha un bilancio eternamente in rosso. E non è il bilancio fatto di numeri e moneta (anche quello tradizionalmente negativo): è il bilancio delle speranze e dei sogni ad essere col segno meno. Una comunità che investe sui suoi giovani, che li cura (attraverso il servizio sanitario pubblico) e li istruisce (attraverso la scuola pubblica) e che, quindi, mette da parte momentaneamente le sue forze più fresche ma che, alla fine, vede queste stesse forze andar via, verso altri lidi, è una comunità che perde. E il Sud Italia è una comunità perdente da troppo tempo. Certo, esistono molte realtà positive ed attrattive, ciascuna con la propria storia da raccontare; ma il dato complessivo è quello di un continuo emigrare di forze giovani e produttive verso contesti più promettenti. Un Futuro che scappa via, una promessa mantenuta altrove. Bologna, invece, deve la sua forza alla sua straordinaria capacità di riuscire a dare e, allo stesso tempo, a ricevere molto.
La bolognesità è una ricetta fatta di solide tradizioni, tra le quali prevalgono quelle della solidarietà e della tolleranza, elementi che rendono la città delle Torri la perfetta meta per tanti studenti. Studenti che, una volta laureati, decidono di ricambiare quanto ricevuto da Bologna: e lo fanno restandoci e popolandola. Difficile lasciarla, Bologna. A volte, il rapporto che uno studente fuorisede (e quindi non pendolare) con le sue due città (Bologna e quella di sua provenienza) è quello che si ha con una coppia di genitori separati. Il legame rimane per entrambi, si cerca di mantenere un contatto, attraverso un difficile dosaggio di affetti e tempistiche differenti. Oppure, proprio come accade con situazioni analoghe, si arriva a preferire un genitore piuttosto che un altro (se non, addirittura, odiarne e sconfessare uno). Chi mantiene un contatto, un rapporto con la sua città di provenienza, e quindi sente ancora come parte integrante del suo Io tutto ciò che la riguarda, sa che prima o poi dovrà rispondere a quella domanda. Molto spesso la risposta è dovuta all’esigenza per eccellenza: il lavoro. Un bene che il Sud Italia non è mai riuscito a corrispondere per davvero, specie negli ultimi decenni, alle sue giovani generazioni. Ma non è l’unico elemento ad incidere: molte piccole realtà provinciali del Mezzogiorno, proprio perché perennemente in perdita nel bilancio delle risorse umane, non sono in grado di offrire un contesto culturale e sociale fresco, attrattivo e vincente. Come un cane che si morde la coda, come un’equazione senza risultato: si vorrebbe “tornare giù” ma “giù è tutto più difficile” e quindi si “rimane su”. E quindi, inevitabilmente, il cerchio si stringe e ricomincia la contraddizione: se non si “torna” le cose non “cambiano” e quindi, non si “torna”. Sono discorsi che fanno, ormai, parte del nostro vocabolario nazionale, dato che possono essere, con qualche accortezza, applicati anche al rapporto Italia-Estero. Eppure, la loro forza ed influenza è enormemente maggiore in certe realtà meridionali e solo chi ha avuto modo di toccare con mano questo tema è in grado di capire l’entità dell’emergenza. Che fai, resti o torni a casa? Una domanda difficile. La classe politica e, quindi, i cittadini meridionali devono lottare per cambiare la risposta. I giovani meridionali devono riconquistare le loro città. Perché, decidere se restare o meno nella brillante Bologna, è più semplice e bello se è davvero possibile sceglierlo.
Alessandro Milito
Alicante (Sabato&Poesia)
Alicante
Un’arancia sul tavolo
il tuo vestito sul tappeto
e sul mio letto tu
dolce presente del presente
Frescura della notte
calore della mia vita.
(Jacques Prèvert)
Spiegare una poesia è sempre commettere un delitto crudelissimo. È come scucire tutto d’un tratto un vestito per capire da dove comincino le rifiniture e di che colore sia la stoffa interna. Ci sono cose che si possono smembrare per guardarle meglio e altre che sarebbe più opportuno forse lasciarle così come sono, intatte. Perché anche le poesie così come i nostri stati d’animo se analizzati rischiano di morire. Capire il perché di una strofa talvolta equivale all’inutilità di capire un nostro atteggiamento. Esiste, è. Senza un significato forzato, senza una parafrasi di sottofondo.
La poesia che ho scelto, infatti, non la spiegheremo. Sarebbe senz’altro sciocco tanto è chiara. Ma la leggeremo cercando di dare un volume più intenso alle parole che ha dentro. Fino alla dimensione scolastica, ero prettamente convinta che la poesia fosse orpello retorico, fosse rima contro rima, fosse una canzonetta ben fatta che cercasse l’approvazione del suo pubblico. Uscita fuori dal dovere di leggerle, ed entrata dentro il piacere di leggerle per volere, ho capito che la poesia era tutt’altro che questo. È, anzi, nella maggior parte dei casi, il tentativo di una persona come noi di fotografare un momento che gli ha donato la sensazione di una sensibilità estrema. Come se il poeta, mentre vive, mentre cucina, mentre ama, si dovesse fermare un attimo per mettere insieme i pezzi di quello che gli è successo.
Siamo ad Alicante, in Spagna. Che è una città di mare. Il poeta ha probabilmente finito di consumare un momento di passione con la donna di cui velatamente ci parla e si mette a descrivere con la semplicità tipica di chi ha nella testa emozioni più forti, e non può badare al resto, l’ambiente circostante.
Sul tavolo c’è un’arancia. Ancora intera o sbucciata o mangiata per metà? Non lo sappiamo. Ma l’arancia ci dà il primo colore presente nella stanza: l’arancione. Gli occhi del poeta cadono ora in basso e sul tappetto c’è il vestito di lei. Il fatto che sia sul tappeto ci dà l’idea della fretta con cui devono essere entrati nella stanza. “nel mio letto tu”. Tu è il nome più bello con cui ci possiamo sentire chiamati da un altro. Perché indica scelta, appartenenza. Sei tu in mezzo agli altri. È un pronome che definisce l’idea del rapporto esclusivo. Il poeta sceglie di chiamare così questa donna. Che ora dorme nel suo letto. Mio e tuo. Lei che è sua dorme in un letto che gli appartiene come lui appartiene a quella donna in quel momento.
Dolce presente del presente. Presente, come sappiamo, non vuole dire solo ora, adesso. Ma presente in italiano vuol dire anche dono. Quindi in un solo verso il poeta riesce a fare due dediche con due significati diversi ma con parole uguali. Può voler dire: donna che rappresenti l’attualità piena di questo momento presente. Ma può voler dire anche: donna che sei il dono di questo tempo che sto vivendo.
Frescura della notte, calore della mia vita. Anche a noi sembra di sentirlo il caldo che quella notte deve esserci ad Alicante. Le persiane completamente aperte e le tende bianche che non si muovono perché non c’è un alito di vento. Eppure quella donna è il fresco, perché è il modo di non pensare a quel caldo. Ed è anche però il forte calore della vita, che invece è fredda . Perché non è sempre estate ad Alicante, ma soprattutto non è sempre estate nella nostra esistenza. E nell’inverno, nelle cadute, nelle sere di prova, quella donna è comunque il riparo, la protezione, è l’idea di un amore che copre tutte le cose.
Ecco, non abbiamo appreso nulla di più rispetto alla lettura inziale, ma abbiamo sicuramente vissuto con altri occhi l’esperienza che in certi momenti ci è venuto naturale fare nostra. Le poesie non parlano quasi mai di cose estranee al nostro vissuto, ma quasi sempre nel raccontarcele ci danno intuizioni nuove per comprendere quelle che erano accadute anche a noi stessi. Non leggetele con snobismo, né col pregiudizio di non poterle mai comprenderle fino in fondo. Leggetele come foste voi i destinatari delle cose che dicono, e come foste voi gli scrittori che hanno bisogno di destinarle a qualcuno.
Veloci, come delle volpi nei sentieri
Qualche sera fa si è svolta la presentazione del libro dell’avvocato penalista Andrea Speranzoni, intitolato “A partire da Monte Sole” ed incentrato sulle vicende delle stragi compiute tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944 dai militari della XVI divisione Reichsführer, coadiuvati dai fascisti italiani, a causa delle quali persero la vita quasi ottocento persone, tra cui 221 bambini di età compresa fra i quattordici giorni di vita e tredici anni. All’incontro c’era anche un testimone chiave delle stragi, il signor Ferruccio Laffi, rappresentato in tribunale proprio dall’avvocato Speranzoni.
La vicenda viene ripercorsa dall’avvocato in un modo pacato, ma deciso, come se ci stesse raccontando una storia dell’orrore inventat. Nell’aula cala un silenzio carico di attesa, rammarico, incredulità a tratti. Le date sono fondamentali per comprendere non solo ciò che accadde a Marzabotto e a Monte Sole, bensì anche ciò che fino al 1994 l’avvocato definisce un vero e proprio insabbiamento delle prove.
Facciamo un salto temporale di cinquantasei anni: siamo nel 1960. Il quattordici gennaio di quell’ anno, il procuratore generale militare, Enrico Santacroce, dispone l’archiviazione provvisoria dei fascicoli che incriminano i responsabili delle stragi. È un abuso di potere, perché l’occultamento non permette la loro spendibilità penale. Nel 1965, la Germania chiede all’Italia di essere messa al corrente di “eventuali” fatti commessi dalle SS in territorio italiano; detto fatto, Palazzo Cesi spedisce i fascicoli alla Repubblica Tedesca, che tuttavia li rimanda al mittente considerandoli “irrilevanti”. Ci si dimentica di queste prove nascoste nell’ armadio della vergogna – così definito dall’avvocato – sino all’estate del 1994, quando l’archivio viene rivelato. Ci si aspetterebbe la conduzione delle indagini dal momento della riapertura dell’archivio, tuttavia, non è così: il primo atto d’indagine è dell’aprile 2002. L’avvocato Speranzoni sottolinea, in modo chiaro e a scanso di equivoci, una vera e propria inerzia da parte dei magistrati, che decidono di non indagare sulle vicende. Nel marzo 2002, il presidente tedesco Johannes Rau incontra il nostro presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi. Rau muove un’accusa grave sulle “iene” che macchiarono di sangue innocente le loro camicie nere, lì a Monte Sole. La molla che incentivò un’effettiva riapertura del caso con indagini serie si deve ad un servizio giornalistico proprio nei luoghi delle stragi. Negli anni 2005 – 2006 le indagini si dichiarano concluse. Il 13 gennaio 2007, viene emessa la sentenza di primo grado che condanna gli otto responsabili delle SS che parteciparono all’eccidio. L’appello contro la sentenza di condanna viene discusso nel 2008, ma la condanna è definitiva: il risarcimento in sede civile nei confronti delle vittime e degli enti pubblici ed otto ergastoli. Qui arriviamo al punto focale del discorso dell’avvocato. Tale risarcimento e tali ergastoli non sono mai stati attuati. Il primo grande interrogativo è: perché? Forse per non incrinare i solidi rapporti tra l’Italia e la Germania? Il processo tenutosi a La Spezia è importante anche, se vogliamo, per uno studio linguistico e psicologico sulle parole e sugli atteggiamenti degli imputati. Nella città ligure, infatti, vennero sentite due ex SS, mentre altre testimonianze vennero raccolte dai giornalisti. Albert Meyer, comandante di squadra che circondò l’oratorio di Cerpiano, sbarrò le porte e lasciò morire cinquanta persone, si vanta di aver trattenuto due giorni le vittime per “farle soffrire di più”. Le parole sono chiavi d’indagine, spie di un sadismo lucido ed efferato, non di una pazzia che vaneggia.
Mi viene in mente Anna Harendt che, nella “Banalità del male”, parla dell’atteggiamento lucido dei più grandi criminali della seconda guerra mondiale, durante il processo condotto nei loro confronti, che quasi guardavano attoniti gli avvocati dell’accusa perché, in fondo, loro avevano “solo” eseguito gli ordini del Terzo Reich. Speranzoni cita solo due dei modi con i quali i soldati tedeschi appellavano le vittime: “bacilli di sinistra” (si fa riferimento proprio all’orientamento politico, giustificando gli omicidi da un punto di vista politico) e “fiancheggiatori delle bande”. Quest’ultimo termine ha qualcosa che va oltre il crudele, perché i “fiancheggiatori delle bande” altro non erano che i bambini. La narrazione della strage non si ferma al processo, bensì continua, perché l’avvocato parla proprio di “silenzio di Stato”: è quello che avvolge, ad esempio, la figura di Carl Hass, agente segreto inserito nella rete di spionaggio americano, che compare in due film (uno del 1962, l’altro del 1969) interpretando un ufficiale tedesco, proprio negli anni ’60, in cui pendeva su di lui un mandato di cattura internazionale. Hass paga per la strage delle Forze Ardeatine solo nel 1998; un suo verbale viene acquisito da un giudice che indaga sulla “strage della tensione” e su Piazza Fontana. Insomma, qui la Storia entra prepotentemente nelle vite della gente, creando legami e nodi inscindibili tra due eventi temporalmente distanti, ovvero appunto gli eccidi del 1944 e l’attentato terroristico di Milano, del 1969, e mette in luce una connivenza tra assassini che, per la gente comune, è quasi improbabile. Qui, emerge anche un altro personaggio importantissimo per comprendere la Storia italiana: è l’intellettuale e regista Pier Paolo Pasolini. Egli, nel 1974, si reca a Gardelletta di Monte Sole per riprendere uno dei suoi film cult, ovvero “Salò o “le 120 giornate di Sodoma”. Pasolini non sceglie proprio quel luogo per un semplice caso: egli è consapevole del messaggio più o meno implicito che, attraverso il film, vuole inviare, ovvero la denuncia della spersonalizzazione e deumanizzazione delle vittime, ridotte a semplici “cose” da parte del nazismo. Tuttavia, alcune riprese furono sottratte nel 1975, anno cruciale per Pasolini: infatti, da un’indagine condotta a Roma, alcune di queste bobine dovevano essere oggetto di scambio, proprio in quell’anno, all’idroscalo di Ostia, in cui venne trovato senza vita proprio il regista. Da notare la modalità con cui fu ucciso Pasolini, il vilipendio sul suo corpo che, stando a quanto afferma con certezza Andrea Speranzoni, fa riferimento all’ideologia reificante del sistema nazista. Tale ideologia rientra anche nel “nuovo modo di essere criminali nell’Italia di quel tempo” (cit.) . Ancora. Luigi Di Gianni, regista, si reca a Monte Sole per parlare con le vittime, perché vuole girare un documentario per la Rai, che però “stranamente” non verrà mai pubblicato. Le verità raccontate dai testimoni scompaiono. Sono gli anni in cui Pasolini sta girando “Accattone”, in cui il personaggio principale, Vittorio, interpretato da Franco Citti, viene definito “mostro umano”, giustificando così la misera fine a cui va incontro. Forse che Pasolini faceva riferimento proprio agli epiteti offensivi con cui le SS appellavano le loro vittime, per giustificare i loro crimini?
Torniamo alle vittime, alle parole, alla loro dignità. Dignità è, ancora una volta, il termine che inquadra meglio l’atteggiamento di Ferruccio Laffi. L’anziano signore quasi si vergogna di raccontare ciò che ha visto e subito. Abbassa la testa, quasi chiude gli occhi per cercare nel buio senza forme quelle parole dolorose che, fino a martedì, non erano mai state raccontate ad un pubblico. Parla piano, incespica nei termini italiani “Preferisco parlare in dialetto, ma so che non tutti potrete capirmi”. Lui era contadino; la sua era una famiglia povera, normale come tante altre. Erano in diciotto in casa: tre fratelli partiti in guerra, i suoi genitori, due cognate, gli altri fratelli e nove nipotini. Si divideva la casa, il letto, il companatico. Si lavorava duro, tanto che non c’era nemmeno tempo per soffermarsi a riflettere sulla guerra che, fino alla mattina del 29 settembre, era sentita come qualcosa quasi di distante. La guerra, però, non solo non era distante, bensì giocava con i fili della vita della sua famiglia, decidendo al momento giusto quando far cadere a terra i suoi burattini. Se le ricorda, Ferruccio Laffi, le cannonate del 29 settembre 1944. I tedeschi corrono rapidi dalle montagne, fanno razzie ai casali vicini. Lui e i suoi fratelli corrono, veloci come volpi nei sentieri del bosco vicino casa. Aspettano lì tutta la notte: l’indomani, tutto sembra finito. Una quiete cala a forza sul paesaggio, quasi come fosse una maschera che nasconde la realtà che sta per svelarsi davanti agli occhi di Ferruccio: giunto a casa, l’orrore gli si palesa davanti con violenza. Diciotto cadaveri, diciotto vite violentate, mutilate, uccise, vilipese. Durante il racconto, Ferruccio non trattiene le lacrime e cade in un pianto liberatorio: “Mi sembra di vederli ancora qui davanti a me” e tende le mani, come per dare enfasi a ciò che dice: “Mio padre era accanto alla porta, tutto rannicchiato, di fronte alle vittime. Gli hanno fatto vedere lo spettacolo prima di ucciderlo…”. L’aula è pietrificata, quasi non respira, non si muove. Vedo una moglie stringere le mani di suo marito e forse quel gesto è il simbolo esterno di ciò che tutti, indistintamente, proviamo. Ferruccio Laffi riprende fiato e racconta della sua odissea personale: dovette nascondersi con altri due amici nei boschi, per sfuggire ai tedeschi. Si cibava di bacche, percorreva i sentieri più impervi “come una volpe”. Viene catturato dai tedeschi che lo portano in degli appartamenti con altre persone, dei “campi di concentramento” come li definisce, in cui lavora duro e manda giù lacrime amare, tutte le volte che sente i colpi di pistola che decretano la fine di un prigioniero, a caso. Riesce a scappare, si unisce ai partigiani fino a quando la guerra finisce. Il suo racconto s’interrompe così. Ciò che più stupisce è la normalità, quella che è seguita dopo queste scelleratezze e che non ha consentito alla giustizia di fare il suo corso, anzi: si è imposta nella quotidianità, dando la possibilità a questi beceri criminali di fare le loro vite indisturbati, portare i nipotini a scuola, ricoprire ruoli importanti, ricevere addirittura medaglie al valor civile nei loro paesi tedeschi. La memoria….La memoria si costruisce non chiudendo gli occhi, non arrendendosi a ciò che sembra e non è, per vigliaccheria, per comodità. La paura di guardare fa chinare il mento, fa credere che ciò non possa essere mai accaduto, perché ci si dimentica di avere una coscienza collettiva che, in quanto tale, deve saper problematizzare. “Anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti” canta De Andrè: come dargli torto?
I libri che non ci hanno ancora cambiato la vita

Ho sempre trovato le classifiche una cosa difficilissima. Scartare il non importante, e decidere qual è il più necessario, questo è un compito un po’ fuori dai pori della letteratura. In cui raramente esistono i primi e i secondi classificati, perché tutto è a suo modo fondamentale se leggerlo ci fa stare bene. I libri sono tutte cose preziosissime. Se qualcuno ha scritto è perché voleva dirci un segreto. Qualcuno diceva “scrivere è sempre nascondere qualcosa in modo che poi venga scoperto”. E lo credo, leggiamo o scriviamo sempre per prenderci o buttare via un segreto che non vogliamo urlare al mondo.
Da questo baule di lettere e segreti, caccio fuori però oggi solo 5 libri. Che non credo siano i più belli in assoluto, ma lo sono stati quanto meno per me e li voglio condividere.
–Il giorno prima della felicità, di Erri de Luca. C’è una Napoli molto chiassosa in sottofondo. Si sente il sapore del caffè davanti al golfo del Vesuvio e ci sono lenzuola bianche stese fuori e ragazzini che giocano a pallone tutto il giorno. C’è un bambino che addentrandosi tra stradine di quartiere scopre una storia di guerra complicata e solo allora il male ci sembrerà una cosa semplice e il dolore una battaglia più conoscibile. Ma soprattutto c’è una domanda: qual è il giorno prima della felicità? Quello in cui riceviamo il bacio che aspettavamo o quello in cui aspettavamo che il giorno del bacio arrivasse? La risposta è la nostra. E l’impresa sarà trovarla.
– La meccanica del cuore, di Mathias Malzieu. Questa è una specie di grande favola con delle metafore di fantasia che hanno però lo stesso grado di realtà del nostro corpo, delle nostre debolezze. La trama non ve la svelo. Perché come in ogni favola che si rispetti è bene sempre lasciare che sia l’immaginazione a comporre le scene, i suoni e gli inizi. Ma c’è una cosa che si impara poco a poco che si legge: il cuore e la meccanica hanno molto in comune. E gli incantesimi a cui diciamo tutti di non credere, perché siamo grandi, sono sempre quelli per cui speriamo che poi alla fine le cose vadano in un altro modo.
–Uno, nessuno, centomila, di Luigi Pirandello. Non c’è bisogno di altre presentazioni. Tutti siamo cresciuti, più o meno consapevolmente, a suono di massime che provenivano da questo romanzo. È vero: siamo più maschera o siamo più volto? Cosa rimane di noi quando gli altri se ne vanno e rimaniamo soli nella stanza? Senza l’umanità a cui dobbiamo il dovere di comunicare, cosa saremmo nel nostro silenzio? E quando le luci si spengono, siamo nessuno o siamo qualcuno nonostante quella luce? Pirandello ci dà materiale per conversare per delle notti intere. Leggerlo è sempre fare un passo avanti dentro di noi. Comprenderlo è sempre fare un passo avanti nella paura che abbiamo di noi.
–L’ultimo dono, di Sandor Marai. Una commuovente dedica che questo splendido autore fa alla moglie negli ultimi anni della sua vita. Un’esistenza che ora si prepara a scoprire cosa c’è dopo la morte, ma che non si sa misurare con la paura di lasciare sola la propria compagna. Un libro in cui si avverte la tenerezza di un uomo, prima che di uno scrittore, che non teme la sofferenza ma il dubbio di che cosa potrà essere quell’amore una volta che il sipario sarà calato. Un libro da leggere non tanto perché faccia ricredere nell’amore, ma perché mai, come in questa opera, si proietta la luce su un amore diverso. Finora avevamo letto quello dei baci dei ventenni o quello delle coppie impazzite. Qui abbiamo un amore maturo che ha superato tutte le prove dell’esistenza e che ora sia avvia alla più spiazzante.
–La gioia di scrivere, di Wislawa Szymborska. Le poesie sono sottovalutate almeno quanto le raccolte di poesia, in Italia. Invece la poesia è proprio la prima scintilla, il primo vagito della creatività di un artista. Nasce con un impatto più spontaneo, e la sua ispirazione è meno costruita. Questa straordinaria poetessa polacca ci insegna che non sono sempre i laghi, i ruscelli o i quadri d’amore a suscitarle poesia. Ma che ci sono anche incroci di strade, fili d’erba, piatti, bicchieri, fogli stracciati che hanno dentro qualcosa di meraviglioso. E li descrive. E ci descrive. E troveremo la nostra esatta vita trasportata nei suoi versi. I nostri dubbi, e le carezze che dichiariamo di volere meno volte delle volte in cui le vogliamo davvero.
Poi c’è un sesto libro, quello che tutti abbiamo dentro di noi. Quello che, almeno una volta nella vita, tutti abbiamo pensato di scrivere. I protagonisti generalmente siamo noi e la storia che avremmo intenzione di trasporre è sempre molto autobiografica. Vi consiglio di farlo realmente, prima o poi. Non è detto che lo darete alle stampe, e non è detto che venderete per forza milioni di copie. Ma raccontarvi vi aiuterà a capirvi e mettere in fila gli eventi, vi farà trovare il significato che di loro vi era sfuggito. Il vostro libro sarà importante proprio come tutti gli altri che avrete letto.
Perché siamo sempre la somma e il resoconto delle storie degli altri unite alla nostra.
Riti prima degli esami
C’è una linea di demarcazione che divide la scaramanzia dal disturbo ossessivo compulsivo. Quando sei in procinto di sostenere un esame universitario, però, quella linea diventa estremamente sottile non facendoti più capire in quale parte ti trovi.
Tutto ha inizio a ridosso dell’esame, quando cominci a seguire alcuni schemi che nel precedente appello avevano portato fortuna; e così, nella tua mente, pensi: “Beh, perché cambiare? Riproviamo!”.
E quindi la sera prima, carico di stress, ti ritrovi ad ordinare la stessa identica pizza dell’ultima volta, mettendo in scena un alquanto improbabile correlazione tra mozzarella di bufala, pomodorini e microeconomia.
Preso dal panico poi ti ricordi che quando la sera prima dell’ultimo esame avevi pulito la camera avevi portato a casa un bel 30; allora senza pensarci su due volte ti metti i guanti di gomma, tiri fuori il secchio dallo sgabuzzino e tiri a lucido la tua stanza così bene che se la vedesse tua madre richiederebbe una perizia psichiatrica.
Tutti gli studenti conoscono la leggenda del “non studiare o ripassare o il giorno prima dell’appello”, insomma lasciar riposare la mente. C’è chi ci crede fermamente e chi, in quell’ultimo giorno, cerca di stampare nella sua mente oltre 1000 pagine conscio del fatto che ricordarsi tutto sarebbe impossibile persino per Dustin Hoffman in Rain man.

Poi arriva la mattina dell’esame: ti svegli presto, vai a fare colazione e inizi a prepararti, il tutto sempre con gli appunti tra le mani; se da piccolo dormivi con il peluche, quando diventi uno studente universitario dormi abbracciando gli appunti.
Non appena arriva il momento di vestirsi la scelta diventa cruciale e, guardando i vestiti appesi nell’armadio, non vedi più i colori o il tipo di capo d’abbigliamento, ma solo il voto che hai preso quando l’hai indossato ad un esame.
Dopo aver fatto un’attenta media ponderata e un rapido calcolo delle probabilità degno del miglior John Nash in A Beautiful Mind, sei ufficialmente pronto per andare all’esame.
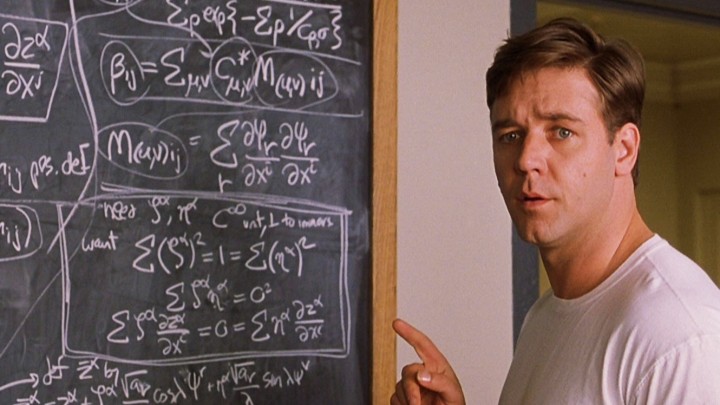
Tutto in discesa adesso? Neanche per scherzo! Già, perché la strada che hai preso l’altra volta per arrivare in facoltà ti ha portato dritto dritto verso un voto alto quindi, perché cambiarla? Allora ripercorri la stessa strada con una precisione tale che a fine esame, a prescindere da come sarà andato, verrai assunto da Google Maps.
Poi se l’esame è scritto ovviamente è immancabile la scelta della penna. C’è chi ha la sua preferita come Paolo Bitta e la sua quattrocolori e chi, invece, la cambia sempre.
Una volta finito l’esame sei provato fisicamente e psicologicamente.
E se non ha funzionato? Beh, si cambia: pizza, felpa, penna, strada e tutte le solite abitudini semplicemente per crearne delle nuove. Funzionerà?
È ai padri che si ritorna
Viviamo in un presente complicato in cui le certezze di sempre sono messe in discussione e non possiamo prevedere con conclusioni affrettate se si tratterà di un fallimento o di un’evoluzione. Fra questi pilastri d’argilla c’è anche la famiglia, la sua concezione, le sue radici e i suoi valori. Senza avventurarsi sui temi delle unioni civili, delle adozioni o della maternità surrogata, riflettevo semplicemente su quanto possa essere frustrante trascorrere la festa del papà o della mamma immuni da cascate nel cuore, qualora sia assente un destinatario per questi auguri. E’ una mancanza che può essere fisica, ma soprattutto emotiva. I vuoti interiori sono soggettivi, indefinibili, e ci si può sentire orfani pur non essendolo, ma per mia immensa fortuna sono ipotesi a me sconosciute. Credo che i figli non siano di chi li mette al mondo, ma di chi li accompagna per mano nella vita, trasmettendo umanità, educandoli all’amore e al rispetto, all’onestà e alla dignità. Ci sono uomini e donne che fanno figli e poi ci sono i padri e le madre.
Di norma diffido per indole dalle date convenzionali, ma il 19 Marzo è una tenera eccezione. Mi piace rinnovare sottovoce la gratitudine profonda che nutro nei confronti di chi ha immortalato la mia infanzia in una collezione di scatti che cresce con me. Alcuni padri compiono gesti eccezionali in nome di questo amore, come Mark Zuckerberg, che, assieme a sua moglie Priscilla, ha commosso il mondo, quando alla nascita della loro figlia Max, si è impegnato a donare il 99% delle sue azioni di Facebook – dal valore di 45 miliardi di dollari – per promuovere il potenziale umano e l’uguaglianza fra tutti i bambini attraverso la Chan Zuckerberg Initiative.
Altri dedicano ai propri figli poesie o canzoni che, anche se diventano successi mondiali, sono scritte soprattutto come fossero carezze intime e private da donar loro ad ogni lettura, ad ogni ascolto.
I più, invece, vicini o lontani, sfidano le difficoltà quotidiane e provano a vincerle per il bene dei loro cuccioli.

Penso ai padri con evidente ottimismo, nonostante non sia possibile generalizzare, ma offenderei la mia storia familiare se non lo facessi. Le sbavature e le incomprensioni sussistono fisiologicamente in tutte le relazioni umane, come in quelle con i padri. Quella paterna è una figura unica e fondamentale che viaggia in prima classe anche con gli scioperi o con i guasti al motore. In senso lato è ai padri che si ritorna quando si cercano le origini dei fenomeni, le radici dei perché, come nel caso dei nostri padri costituenti.
E’ ancor più particolare il rapporto che si instaura fra i padri e le figlie, perché condiziona inevitabilmente lo sguardo che queste avranno sugli uomini, il modo in cui li ameranno, il rispetto che da loro pretenderanno.
Parte di qui il grado di aspettativa che non è la prosecuzione del filo paterno, ma un trampolino verso la sfera maschile nella quale ci si orienta anche grazie a quel linguaggio non verbale appreso a casa.

Ricordo certe frasi di mio padre, che nel bene e nel male, hanno condizionato la mia infanzia e la mia crescita, come quando a sei anni mi ha insegnato a prelevare ad uno sportello bancario, svelandomi con fiducia quelle cinque cifre segrete ed emancipandomi con così poco. Oppure quando qualche anno dopo mi ha spiegato in poche parole la differenza fra la destra e la sinistra, che “pensa un po’ di più alla gente poverella e per bene come noi”. Ha custodito per sempre la mia infanzia e quella dei miei fratelli in pellicole chilometriche di bagnetti, vacanze al mare e primi giorni di scuola, oltre all’infinito repertorio fotografico, prezioso come noi. Mi ha accompagnata a scuola per sedici anni dal primo giorno di asilo all’ultimo del liceo, cantando Battisti o in silenzio assonnato, cercando invano un dialogo mattutino o nervoso nel traffico, ma sempre abilissimo alla guida e, molte volte, in ritardo! 
L’ho visto piangere in un paio di circostanze anche se non avrei voluto, ma è servito per conoscere meglio la sua profonda sensibilità, che è l’obiettivo della sua macchina fotografica. Non sa tutto di me – perché nessuno lo sa – e le distanze esistono fra di noi, però non mancano le ragioni per accorciarle, come quella fiducia incondizionata nei miei confronti che non mi abbandona mai e mi fa sentire contemporaneamente libera e protetta. E’ curioso della mia opinione e crede in me, sempre. Questa certezza non ovvia è come un vento che soffia dentro e scuote le parti migliori di me, che pensano al domani col sorriso.
Ho votato No. Ma non mi sento un mostro per questo.
A nostre spese abbiamo imparato che ogni discussione post elettorale che si rispetti oramai si giochi sulle piattaforme dei social network . Abbiamo anche imparato di come più che una discussione si tratti di serie di monologhi moralizzatori che di regola vengono lanciati al cittadino che non ha fatto il suo dovere, al cittadino che non è degno di essere chiamato tale, al cittadino che, seguendo le indicazioni di questi appelli, dovrebbe letteralmente nascondersi e non farsi vedere in società per almeno un paio d’anni.
A me, non piacciono le generalizzazioni ed, onestamente, non mi piacciono nemmeno quelli che vogliono fare i portatori sani di coscienza civica solo per un giorno. Perché sì, ammettiamo che dia anche la sensazione di un certo potere raccogliere like virtuali facendo i Che Guevara della situazione, però ogni monologo, ogni appello, ogni discorso deve avere con sé le radici del rispetto verso il discorso dell’altro. Anche il silenzio ha la sue ragioni. Possiamo non condividerlo e possiamo ritenere quelle ragioni vane, ma la prima lezione di democrazia da cui ripartire, a mio avviso, è proprio quella di comprendere il silenzio civico nel suo significato.
Nella votazione referendaria di ieri il silenzio era una risposta specifica. Che ci piaccia o no, il referendum abrogativo nasce proprio con il vincolo di un quorum elettorale da raggiungere. Quindi, se voglio esprimere il mio dissenso rispetto alla proposta che mi viene fatta politicamente, posso decidere di non andare a votare contribuendo al non raggiungimento del quorum e quindi al suo fallimento. Certo, c’è chi potrà ravvisare in questo comportamento un atteggiamento di non considerazione rispetto alle sorti del paese, ma c’è chi leggendo più lucidamente, potrebbe anche notarci una concreta presa di posizione contro la consultazione referendaria.
Poi che, ovviamente, ieri ci siano stati milioni di italiani che non abbiano votato per pure ragioni di noia, di disinformazione, di distanza dal problema, anche questo è legittimo credere che sia accaduto. Ma ce ne sono stati molti altri che non hanno votato perché erano con consapevolezza contrari alla riuscita di questa consultazione. È sempre facile fare un grande mucchio di tutte le personalità e di tutte le vicende, perché, ammucchiando e omologando, quando si punta il dito contro non si deve fare lo sforzo di distinguere tra le ragioni dell’uno e dell’altro. Ma distinguere è sempre il primo passo per scegliere cosa conoscere.
Io ho votato, ma ho votato No. E non mi sento un mostro per questo. E, malauguratamente, non sono nemmeno la figlia del proprietario di un pozzo petrolifero nell’  Adriatico. Ho votato no perché questo quesito era posto malamente e non ravvisavo nella legge attuale una grave minaccia. Non ho una conoscenza ambientale così specifica, ma con i miei mezzi ho cercato di informarmi. E posto che, da nessuna legge attualmente vigente, è previsto l’ impianto di nuove trivelle, si sarebbe trattato esclusivamente del decidere se continuare a mantenere in vita quelle già esistenti fino all’ esaurimento dei pozzi sottostanti. Io ho votato affinché queste si mantenessero in vita perché credo che non si possano smantellare di colpo creando il problema della disoccupazione in circa 7.000 lavoratori e rispettive famiglie. Ho votato no perché credo che il fatto che questi impianti si trovino a 12 miglia dalla costa garantisca comunque il rispetto di un certo vincolo ambientale. E ho votato no perché credo, forse scioccamente, che di questo petrolio ne abbiamo ancora bisogno. Perché ritengo che l’energia rinnovabile non la potremo avere domani, ma che prima serva un piano effettivo che programmi con gradualità ed intuito in toto il rinnovamento. E se questo piano di rinnovamento ed investimento non lo abbiamo già pronto, finirebbe che comunque dovremmo compensare l’attesa andando ad importare il petrolio all ’estero.
Adriatico. Ho votato no perché questo quesito era posto malamente e non ravvisavo nella legge attuale una grave minaccia. Non ho una conoscenza ambientale così specifica, ma con i miei mezzi ho cercato di informarmi. E posto che, da nessuna legge attualmente vigente, è previsto l’ impianto di nuove trivelle, si sarebbe trattato esclusivamente del decidere se continuare a mantenere in vita quelle già esistenti fino all’ esaurimento dei pozzi sottostanti. Io ho votato affinché queste si mantenessero in vita perché credo che non si possano smantellare di colpo creando il problema della disoccupazione in circa 7.000 lavoratori e rispettive famiglie. Ho votato no perché credo che il fatto che questi impianti si trovino a 12 miglia dalla costa garantisca comunque il rispetto di un certo vincolo ambientale. E ho votato no perché credo, forse scioccamente, che di questo petrolio ne abbiamo ancora bisogno. Perché ritengo che l’energia rinnovabile non la potremo avere domani, ma che prima serva un piano effettivo che programmi con gradualità ed intuito in toto il rinnovamento. E se questo piano di rinnovamento ed investimento non lo abbiamo già pronto, finirebbe che comunque dovremmo compensare l’attesa andando ad importare il petrolio all ’estero.
Probabilmente una scelta ignorante, discutibile, ed arrogante la mia. Ma comunque, una scelta. Che merita lo stesso rispetto che meritano tutte le altre risposte di questo paese.



